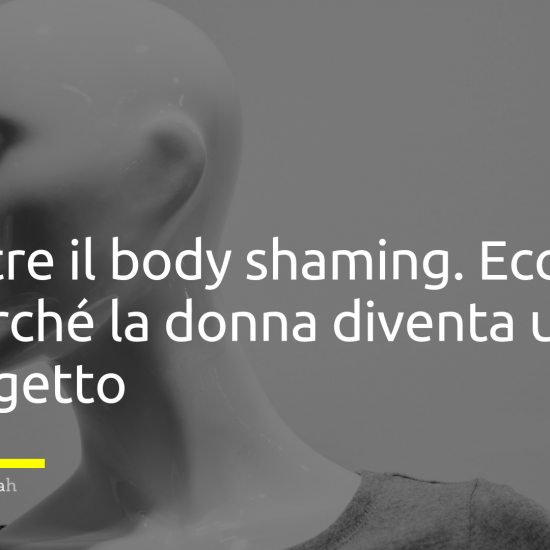Nel 2023, la catena tedesca Penny, parte del gruppo REWE, ha lanciato un esperimento destinato a far discutere: l’esperimento Penny sul vero costo del cibo. Per la prima volta, un supermercato ha mostrato ai propri clienti quanto i prezzi sugli scaffali non riflettano il reale impatto ambientale e sociale dei prodotti che acquistiamo ogni giorno.
Per una settimana, in tutti i 2150 punti vendita in Germania, nove articoli sono stati messi in vendita con un doppio cartellino: il prezzo normale e il “vero prezzo” – quello che includeva anche i costi ambientali e sociali nascosti dietro la loro produzione (ci arriviamo tra un attimo).
Il progetto, chiamato “True Cost” o “Vero Prezzo”, è stato realizzato in collaborazione con il Politecnico di Norimberga e con il Centro per la Sostenibilità della Università di Greifswald e ha suscitato enorme attenzione a livello internazionale.
Indice
Il concetto di “prezzo reale”: le cosiddette esternalità
Facciamo un attimo chiarezza su cosa intendiamo con “vero prezzo”. Normalmente, anche se può sembrare controintuitivo, i prezzi nei supermercati non riflettono i costi totali di ciò che consumiamo.
Dietro ogni euro risparmiato alla cassa, c’è spesso un costo nascosto che viene pagato altrove — da qualcun altro, in un altro momento, o in un’altra forma.
Questi costi vengono chiamati “esternalità” e sono effetti collaterali di un’attività economica che non vengono pagati da chi li genera.
Nel caso del cibo, le esternalità includono:
- l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere dovuto all’agricoltura intensiva;
- le emissioni di metano degli allevamenti;
- la perdita di biodiversità legata alle monocolture;
- i problemi di salute derivanti dall’uso di pesticidi;
- il degrado del suolo, che riduce la capacità futura di produrre alimenti.
Ebbene, come si può immaginare questi costi sono reali ma non compaiono sullo scontrino.
Li paghiamo infatti in altri modi: con tasse per bonificare le aree inquinate, con il deterioramento della salute pubblica, con gli effetti della crisi climatica che richiedono sempre più fondi pubblici.
In altre parole, paghiamo comunque, ma non nel momento dell’acquisto (e spesso senza saperlo). In questo senso, l’esperimento Penny sul vero costo del cibo ha trasformato in realtà un concetto spesso solo teorico: quello di rendere visibili i costi nascosti della produzione alimentare.
L’esperimento: cosa ha fatto il supermercato Penny
Durante quella settimana, Penny ha applicato il principio del “vero prezzo” a nove prodotti scelti tra i più comuni nel carrello della spesa: mozzarella, wurstel, yogurt alla frutta, formaggi e bevande.

I prodotti selezionati
Il nuovo prezzo era frutto di un calcolo condotto dal gruppo di ricerca coinvolto nel progetto, che ha stimato l’impatto complessivo della filiera produttiva su ambiente e salute.
Per giungere al “vero prezzo”, sono stati considerati diversi fattori: le emissioni di gas serra (CO₂ e metano), l’uso di pesticidi e fertilizzanti, il consumo di acqua e suolo, gli effetti sulla biodiversità e i danni indiretti alla salute umana.
Le differenze rispetto ai prezzi abituali sono state notevoli: la mozzarella è passata da 0,89 a 1,55 euro, i wurstel da 3,19 a 6,01 euro. In media, un aumento tra il 60% e il 90%.
Durante l’esperimento, i clienti potevano scegliere liberamente quale prezzo pagare: quello tradizionale o quello che teneva conto dell’impatto ambientale. Così facendo, la scelta è diventata un’occasione per riflettere sul legame tra convenienza economica e sostenibilità.
Le sovvenzioni che alterano il mercato
A rendere ancora più complesso il quadro c’è il ruolo delle sovvenzioni statali.
In Europa, la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta uno dei capitoli di spesa più consistenti del bilancio dell’Unione: oltre 50 miliardi di euro l’anno, di cui più dell’80% finisce nelle mani dei grandi produttori e allevatori intensivi.
Queste sovvenzioni — nate originariamente per garantire la sicurezza alimentare e il reddito degli agricoltori — oggi mantengono artificialmente bassi i prezzi di prodotti ad alto costo ambientale come carne, latte e derivati.
Il risultato è un mercato distorto, in cui i prodotti più dannosi per l’ambiente risultano i più economici, mentre quelli vegetali o biologici — spesso più sostenibili — appaiono come un lusso.
Per esempio:
- gran parte dei fondi europei va a sostenere coltivazioni di mais, grano e soia destinate ai mangimi animali;
- solo una piccola parte finanzia pratiche rigenerative o l’agricoltura biologica;
- gli allevamenti intensivi continuano a ricevere sussidi pur essendo tra le principali fonti di emissioni climalteranti.
In sostanza, paghiamo due volte: prima con le tasse che finanziano le sovvenzioni, poi con i danni ambientali e sanitari prodotti da un sistema alimentare insostenibile.
Come hanno reagito le persone al “vero prezzo”
Durante la settimana del progetto True Cost, Penny ha registrato un calo significativo delle vendite dei prodotti il cui prezzo era stato aumentato (nonostante l’opzione di pagare il prezzo “normale”).
I risultati dell’esperimento Penny sul vero costo del cibo mostrano quanto il prezzo influenzi i comportamenti di acquisto più della consapevolezza ambientale.
Molti clienti hanno dichiarato di comprendere il senso dell’iniziativa, ma di non potersi permettere quei prezzi. E questo è, paradossalmente, il punto: la sostenibilità non può ricadere sul consumatore, sulla consumatrice.
Dal punto di vista psicologico, l’esperimento conferma che le persone agiscono più per convenienza che per convinzione.
Infatti anche chi è consapevole dell’impatto ambientale tende a scegliere in base al prezzo immediato e non al costo collettivo. È un classico caso di bias del presente: tendiamo a privilegiare benefici immediati rispetto a vantaggi futuri, anche se questi ultimi sono oggettivamente più rilevanti.
In termini di economia comportamentale, il prezzo è la leva decisionale più potente: quando i costi aumentano visibilmente, i comportamenti cambiano, ma se restano nascosti — come accade nel sistema attuale — è difficile che la consapevolezza da sola basti a orientare e cambiare le scelte.
L’esperimento Penny ha reso evidente questa dinamica: quando la realtà economica si allinea con quella ecologica, le priorità dei consumatori cambiano, non perché improvvisamente diventino “più green”, ma perché cambia la struttura degli incentivi.
I prezzi reali contano (più delle campagne di sensibilizzazione)
Mettere in chiaro il “vero prezzo” di un prodotto è un modo per ripristinare la trasparenza e responsabilizzare chi acquista.
Solo conoscendo il costo reale — ambientale, sociale, sanitario — possiamo costruire un mercato più equo.
Il concetto di True Cost Accounting (contabilità del costo reale) è già applicato in altri settori, ma nel cibo ha un potere educativo enorme: rende tangibile l’impatto di ciò che mangiamo.
Un hamburger da 2 euro non è davvero “economico” se per produrlo servono 15.000 litri d’acqua e si rilasciano decine di chili di CO₂.
Il suo prezzo basso è semplicemente sbagliato.
La trasparenza, in questo senso, non serve solo ai consumatori ma anche ai decisori politici. Sapere quanto costa davvero un litro di latte o un chilo di carne aiuta a ripensare le politiche agricole, gli incentivi e la tassazione.
Le sovvenzioni vanno riformate
Sia chiaro, le sovvenzioni agricole non sono di per sé negative: nascono per sostenere un settore vulnerabile ai cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Ma il modo in cui vengono distribuite oggi è quantomeno anacronistico.
- Distorsione del mercato. Sostenendo le produzioni più inquinanti, le sovvenzioni disincentivano l’innovazione e l’agricoltura sostenibile. È un circolo vizioso: chi produce carne intensiva riceve più fondi, quindi continua a produrre di più, mentre chi investe in alternative vegetali fatica a competere.
- Contrasto con gli obiettivi climatici europei. Le stesse istituzioni che promuovono il Green Deal finanziano, con la PAC, attività che aumentano le emissioni. Secondo alcune stime, oltre l’80% delle emissioni agricole europee deriva da produzioni che ricevono sussidi diretti.
- Ingiustizia sociale. I costi ambientali di questo modello ricadono soprattutto sulle fasce più vulnerabili: popolazioni rurali, giovani e generazioni future. È una forma di debito ambientale che si accumula nel tempo.
- Mancanza di trasparenza. Poche persone sanno realmente dove finiscono i fondi pubblici della PAC. La mancanza di chiarezza impedisce di valutare l’efficacia delle politiche e di richiedere cambiamenti concreti.
Cosa possiamo imparare dal caso Penny
L’esperimento Penny, anche se poco noto, è stato un esperimento di coscienza collettiva. Ha mostrato che, se il prezzo rispecchiasse davvero i costi ambientali, molte delle nostre abitudini alimentari apparirebbero insostenibili non solo per il pianeta, ma anche per il portafoglio.
Le reazioni del pubblico sono state contrastanti: c’è chi ha elogiato l’iniziativa come un passo verso la verità e chi l’ha criticata come un esercizio simbolico, poco praticabile su larga scala. Ma in entrambi i casi ha avuto successo nel suo scopo principale: stimolare un dibattito.
In termini di impatto comunicativo, l’esperimento Penny sul vero costo del cibo ha fatto ciò che la politica spesso non riesce a fare: ha tradotto un concetto complesso — il costo ambientale — in qualcosa di immediatamente comprensibile e quotidiano, ovvero il cartellino del prezzo.
Pagare meno, ma meglio
L’obiettivo non è far pagare di più i consumatori, ma redistribuire in modo più giusto i costi. Significherebbe spostare gli incentivi pubblici dalle produzioni inquinanti a quelle rigenerative, aiutando i produttori a cambiare pratiche e i cittadini e le cittadine a fare scelte sostenibili senza dover spendere di più.
Un sistema di prezzi reali premierebbe la coerenza: chi produce nel rispetto del suolo, dell’acqua e del clima dovrebbe essere avvantaggiato, non penalizzato.
Come scrive la fondazione True Price, “non si tratta di rendere il cibo più caro, ma di rendere il mondo più giusto”.
Il prezzo basso ha un costo alto
Lo sappiamo già per il fast fashion, forse ci facciamo meno caso per il cibo, ma ogni prodotto ha una storia — di risorse, di emissioni, di lavoro umano — e nasconderla dietro un prezzo ridotto significa rinviare un conto che, prima o poi, qualcuno dovrà pagare.
Mostrare il “vero prezzo” è un invito a guardare la realtà in modo più completo e, forse, se iniziassimo a farlo più spesso — nei supermercati, nelle politiche e nelle nostre scelte quotidiane — il costo della sostenibilità non ci sembrerebbe più un lusso, ma una forma di lucidità collettiva.